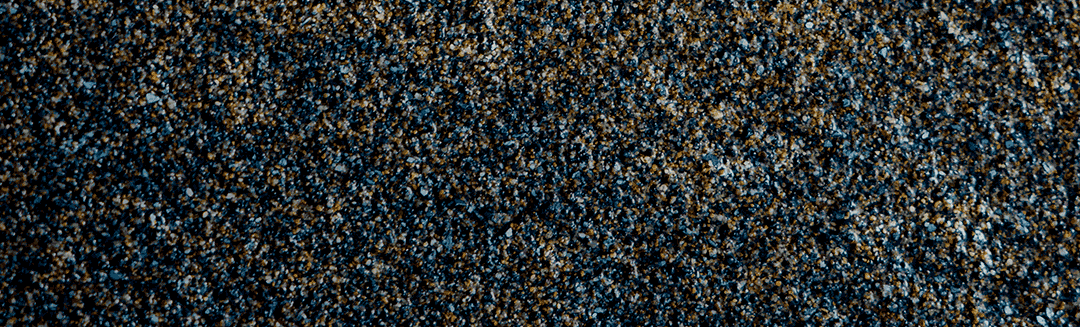Tempo
Il Tempo è un eterno enigma: ci riporta ad uno spazio radicato nel passato e proiettato nel futuro. Ma cos’è, è qual’è la sua forma? E’ lineare, circolare, interna, esterna, ciclica, a spirale? Finita o infinita, narrativo o ripetitivo? Quando finisce il passato ed inizia il presente? Dove finisce il presente, quando è passato?
Non abbiamo risposte definitive eppure la vita di Tutto è soggetta al Tempo. E’ la dimensione attraverso la quale si misura lo scorrere degli eventi come semplice costruzione di principio, astratta e determinata dall’umana necessità. Su di un piano filosofico si rilevano grosso modo due modi di sistemi di misura, quello quantitativo, frazionabile e matematico –Chronos- e quello qualitativo, associato ad un valore, o archetipo –Kairos-. La qualità del tempo non ha a che fare con la sua durata, ma afferma che ogni punto-sezione del tempo, che sia un’ora o un lustro, possiede una determinata qualità che consente l’emergere di quei fatti che sono adeguati a quella qualità. In altre parole che in quel determinato momento possono realizzarsi solo quei fatti i cui contenuti qualitativi corrispondono alla relativa qualità del tempo: un’associazione che caratterizza e identifica il tempo che grazie a quel modello è possibile interpretare sino a misurarlo. Molte scienze sapienziali come l’astrologia, la medicina, la magia si basano su Kairos: sapienti, scienziati, sciamani e sacerdoti sono in grado di leggere il tempo dalla posizione dei pianeti, dalle viscere degli animali, dal volo degli uccelli: Oroscopo significa propriamente guardare nell’ora. La corrispondenza stessa tra macrocosmo e microcosmo vale anche sul piano temporale, dove ogni istante può contenere e riassumere in sé l’eternità intera: soprattutto il momento iniziale di un accadimento viene considerato decisivo, come un seme contenente in sé l’intera pianta, e da qui la consapevolezza di agire nel Tempo kairos, il momento opportuno, ossia corrispondente alla qualità del risultato che si vuole ottenere. Esempio di kairos è la sincronicità jungiana, dove lo psicologo disegnava la reciproca influenza o interazione tra due eventi, che non è da intendere in senso causale ma è dovuta al fatto che entrambi hanno avuto origine nello stesso tempo-contesto, sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda. Ecco, chi si occupa di musica conosce bene il senso di tutto ciò, perchè nella vita musicale si associa il Tempo al ritmo: il tempo Chronos è studiato nel ritmo attraverso l’esatto frazionamento, la pulsazione, e ciclo di pulsazioni regolari che determina il ritmo metrico; allo stesso tempo, chi ha esperienza di improvvisazione musicale come di composizione, conosce bene la sensazione di Kairos e della qualità del tempo.
I punti di vista dunque cambiano se a parlarne è un religioso, un fisico, un musicista, o uno storico. Tra una pulsazione e l’altra, come tra un battito e l’altro, si determina uno spazio che è potenzialmente sia Chronos che Kairos, il Tempo come Intervallo-distanza. Intervallo che si regge collegando il battito/pulsazione già avvenuto con quello che verrà, dunque, in un’azione creativo-propulsiva, che ha una direzione inesorabile, sempre in avanti: la vita passata (o il ricordo di essa) viene gettata nel futuro attraverso lo strumento dell’adesso. Questa distanza è contemporaneamente unitaria che ciclica: l’unità pulsante può essere un secondo o un secolo, perchè il secondo è una somma di battiti e il secolo è la somma di secondi.
Per qualsiasi performer lo spazio che intercorre tra due pulsazioni, come l’intervallo che separa due altezze di suono, è da dimensionare in un percorso: percorso da coprire attivamente, se possibile creatività. Per questo, come ogni percorso di semina, ogni atto creativo, è da considerarsi né più è meno come un viaggio. Se un viaggiatore non alleggerisce la sua storia personale, il suo cammino diventa ogni giorno più pesante e privo di energie vitali. Il passato deve poter essere assorbito profondamente, come un’istinto cosciente. Ma non esiste più, in un certo senso. E il futuro, quello sì, siamo tutti d’accordo nel dire che non esiste ancora.Tutto dipende da che uso faremo, allora, di questo unico istante di cui dobbiamo imparare a conoscere il retaggio (il passato) e la promessa (il futuro): da quale trama arriva la costruzione del mio presente? Che cosa sono chiamato a seminare, ora che Chronos e Kairos cominciano a mostrarsi come lo spaziotempo che mi è stato concesso? Il primo passo che un viaggiatore compie in relazione al Tempo è distaccare un evento da qualsiasi giudizio ed opinione che la sua personalità automatica condizionata è portata a esprimere su di esso. Per compiere questo passo, un viaggiatore si addestra a percepire anzichè pensare. Quando ad un evento togliamo tutto ciò che è opinione/critica/giudizio, stiamo compiendo una operazione magica che gli Sciamani chiamano Cancellare la Storia Personale. L’evento comincia ad illuminarsi di una luce differente, e cominciano ad apparire le connessioni reali. Ovvero l’interrelazione reale, fondamentale, che sottende l’evento. La verità. Da quel momento il viaggiatore entra in relazione con la misteriosa entità chiamata Tempo: osserva venire fuori i fatti, la nuda realtà, e conseguentemente la verità. Comincia a vedere che l’evento non è nato dal nulla, che ogni accadimento è collegato, ed è questo collegamento la cosa più importante di tutte per la sua coscienza. Infine ad assumersi la responsabilità totale. La sua coscienza diventa lo strumento principale con cui indagare la sua vita passata attraverso il presente, incidendo sul suo destino. Allora il Tempo è forse questo: lo strumento con cui un viaggiatore osserva e agisce su ciò che il passato gli mostra da risolvere, attraverso la vista della sua coscienza; ma non soltanto questo. Il Tempo diventa lo strumento con cui un viaggiatore forgia il suo destino, potremo dire alla luce della verità. Quando tutto questo può accadere? Soltanto ora, adesso, in questo unico istante. Ciò che si dipana in questo unico istante è completo, legittimo figlio di ciò che è stato seminato nel passato. E quindi in questo unico istante si deve agire. Ciò che il destino riserva è il risultato di ciò che si determina nell’unico momento possibile dell’adesso, e cioè in questo unico istante. Passato e futuro si annullano nella vita di quell’intervallo, dove si ha totale responsabilità della verità che in esso si metterà, attraverso le scelte che in esso si operano. Qualsiasi azione creativa e dinamica si risolve nell’adesso. E non può essere che così, perché la vita è esattamente la risposta alla domanda. E questo processo può essere vissuto in modo ricco, profondo e risolutivo se collaboriamo con questa verità, abitando coscientemente il Tempo, l’intervallo di quest’unico istante.
Stefano Battaglia
Cre(azione) / Individuo e creatività
L’IO-DIO
Sembra banale ricordarlo ma la creatività ha a che fare con la creazione, dunque ha bisogno di un creatore. E forse anche dell’ambizione di contattare ciò che è divino. La rivelazione potrebbe essere accorgersi che esiste anche una parte di divino in ognuno di noi, potenzialmente, e dunque essere in grado in un secondo momento di vivere e crescere in quella zona, la nostra zona divina, appunto. Quando parlo di divino intendo riferirmi a qualcosa che ha a che fare con una bellezza che è al contempo soggettiva ed oggettiva, è collegata alla verità individuale e a quella universale. Il senso estetico non c’entra nulla, essendo frutto di retaggi e principi soggettivi, filosofie passeggere, spesso collettive e condivise, ma difficilmente universali. Il divino ha sempre a che fare con una verità profonda e dunque non per forza con la bellezza in un senso estetico: la pioggia o un fiore sono sempre espressione divina (e dunque sempre belli) in quanto tali. La pioggia crea e dona, come il fiore. La loro bellezza è persino concretamente collegata. Evidentemente. L’uomo è divino? Certamente la donna sì, verrebbe da dire. Ma in un senso universale e asessuato? Quale bellezza è in grado di sprigionare nel cosmo? Qual’è la sostanza permanente, anche se metafisica, in grado di rendere la sua presenza utile all’universo intero? L’arte, in quanto espressione profonda del sé individuale, dovrebbe proprio essere la rivelazione, il segno, il linguaggio in grado di esplicitare il divino, manifestarlo, descriverlo e raccontarlo, proprio in quanto nucleo essenziale veicolato attraverso processo creativo.
Siamo di certo tutti d’accordo nel sostenere che ci piacerebbe, idealmente, vi fossero tanti creatori, e che, allo stesso modo, tutti preferiremmo sempre convivere, altrettanto idealmente, con creatori coscienti: in-coscienza.
L’Io è l’individualità umana, indivisibile, resa potenzialmente perfettibile a sua volta dai suoi creatori. Come tale si manifesta sempre in un “corpo planetario” sessualmente differenziato, maschile o femminile. Averne dunque la sensazione significa sentirne la presenza nell’azione e nel volere. L’Io è lo spirito divino reso per una manciata di anni carne e sangue, cioè materia fisica nell’uomo. Quando pronunciamo la parola Io ad alta voce possiamo sentire dove risuona in noi questa parola? Nel corpo fisico? Nello spirito? Nell’intelletto?
Quando l’Io si manifesta ciò deve avvenire anche sul piano fisico, come quando l’istinto cosciente ci porta a compiere una dinamica attiva con tutto il corpo, come deglutire liquidi, piangere, digerire, correre o reagire di scatto a qualche improvviso e minaccioso pericolo. Tale esperienza, che rientra nell’ambito che non è dell’immaginazione, non del pensiero, non del sentimento e nemmeno della volontà, è quanto mai più rara e preziosa se e quando assaporata fuori dal contesto di meccanismo. Se l’Io c’é, è comunque difficile che si presenti come un contenuto per la coscienza cosciente. Rimane per lo più inconscio e meccanico, appunto: ma con un pò di lavoro possiamo istruire la sensazione dell’Io. Ma ciò che mi interessa, parlando di creatività, è mettere in evidenza è il rapporto particolare tra Io e Dio. Debbo fare una piccola parentesi: la parola anima non ha pendenze con aspetti -eventualmente- religiosi. A me basta partire dal presupposto comune che tra gli interlocutori si accetti il principio per il quale l’individuo è formato da una parte fisica ed impermanente ed un’altra meta-fisica, eterico-esserica appunto, probabilmente -possibilmente- permanente, almeno in potenza. L’ unico vero istruttore per l’anima umana é in realtà l’Io stesso.
E per ciò che riguarda l’anima autocosciente, bisogna chiedersi se sia addormentata o sveglia. E se dorme sogna, ed ecco dunque dei segni della presenza inconscia dell’Io. Dal sonno al risveglio, alla morte e alla rinascita, ecco l’itinerario dell’animo umano. E se in questo itinerario l’uomo non svolge il suo compito sulla terra in rapporto al sistema solare ecco che muore come un cane e la sua morte fisica rappresenta anche la fine dell’Io.
Il nesso tra Io e Dio (qualunque nome egli abbia, beninteso) è di analogia: è stato detto e affermato
da tutte le religioni che l’uomo è stato creato da Dio a sua immagine somiglianza. Egli ha dato alla nostra presenza generale una struttura che ha la possibilità di inglobare e di manifestare le proprietà che Egli ha in sé stesso. Egli è Dio e di conseguenza anche io sono dio. La differenza è, diciamo così, di scala. Egli è il Dio di un mondo grande ed infinito ed io dovrei essere, io stesso, il dio di un mondo piccolo e particolare. Egli è il Dio di tutte le presenze dell’universo e di tutto il mondo esteriore. Anch’io sono dio, ma di tutto il mio mondo interiore. In tutto e per tutto abbiamo (in potenza) le stesse possibilità e le stesse impossibilità in scala infinitamente diversa e questo è un pensiero semplice ed una grande responsabilità.
Proviamo a considerare l’Io come spirito vivente incarnato in tre corpi dotati di tre “cervelli”, un Io che è triplice e unitario al tempo stesso, uno e trino come il Dio delle religioni, dotato delle funzioni del movimento-corpo, del pensiero-intelletto e del sentimento-spirito. Non bisogna certo confondere la vera e propria individualità, lo spirito incarnato in questo corpo, con il senso di identità superficiale che deriva dall’identificazione con questo o quel gruppo di io (minuscolo) che compongono la personalità. Del resto la parola individuo non è bellissima? Nel suo senso etimologico significa che non si può dividere. Per evitare qualsiasi confusione è bene parlare di Io e io. La lettera maiuscola sta ad indicare la vera individualità, l’essenza, l’Io permanente e la lettera minuscola l’ego, gli aspetti mutevoli e le personalità.
Ricorre frequentemente il concetto per cui l’uomo è una pluralità. L’uomo è paragonato a una casa senza padrone né sovrintendente, occupata da una moltitudine di servitori -le personalità- che hanno interamente dimenticato i loro doveri perché identificate in altro, fuori dal sé, i nostri modelli, i nostri eroi: nessuno fa ciò che deve; ognuno cerca di essere il padrone, non fosse che per un momento, e, in questa specie di anarchia, la casa è minacciata dai più gravi pericoli. La sola speranza di salvezza è che un gruppo di servitori più sensati si riuniscano ed eleggano un sovrintendente temporaneo, cioè un sovrintendente delegato. Quest’ultimo può allora mettere gli altri servitori al loro posto.
In questo modo, la “casa” può essere pronta per l’arrivo del vero sovrintendente, il quale a sua volta preparerà l’arrivo del vero padrone, che va generato con responsabile pazienza. L’arte, se con questa parola vogliamo intendere l’espressione del sé profondo (dell’Io) in qualsiasi forma, è la voce del vero padrone, del suo desiderio urgente di emergere/rinascere. L’espressione dei vari sovraintendenti, o delle personalità, spesso accostate all’arte in un unico enorme denominatore comune, in realtà andrebbe chiamata diversamente. In alcuni casi persino artigianato, che in sé potrebbe essere assai efficace, risulta troppo vago. Il paragone dell’uomo e della casa oltre ad apparire sotto varie forme in molte parabole dei Vangeli, è frequente anche negli insegnamenti orientali che hanno conservato tracce dell’antica conoscenza. Comunque, anche se l’uomo comprendesse nel modo più chiaro le sue possibilità, questo non lo farebbe progredire di un solo passo verso la loro realizzazione. Per essere in grado di realizzare queste possibilità deve avere un desiderio di liberazione molto forte, deve essere pronto a sacrificare tutto, a rischiare tutto per la propria unità.
Quello sforzo supremo (jihad, nel Corano) e la sua tensione è, in sintesi, la sostanza dell’arte.
E fin qui l’Io e la sua relazione intima con l’Individuo: ma come si colloca, rimane da chiedersi, l’Io in rapporto al mondo esterno, a ciò che può essere considerato come non-io? Vale a mio parere la considerazione di stampo tradizionale per la quale la natura è un semplice organismo vivente. E’ la filosofia pre-galileiana che costituisce la base su cui si erge l’edificio dell’alchimia: la natura come organismo, visione del mondo primitiva e teologica degli shamani, che sarà abbandonata, soprattutto dall’Illuminismo in poi, per l’idea della natura come meccanismo. Tutto vive e l’essere umano fa parte della natura in quanto dotato di un corpo fisico-eterico, in quanto organismo biologico. Ma in lui vive il ricordo dell’Io, dello spirito prima della caduta, della sua natura di deva, angelica, divina. L’autoreminiscenza però deve essere attivata, altrimenti l’oblio di sé sprofonda l’uomo sempre più nella meccanicità. Lo spirito incarnato si dimentica spesso di sé, quasi sempre, dorme così nella materia e alla fine rischia di perdere ogni possibilità di tornare all’origine, morendo nello spirito. La natura di cui l’uomo fa parte, con i suoi tre regni, costituisce la vita organica sulla terra. L’uomo occupa rispetto alle pietre, ai vegetali, agli animali un posto speciale nella natura.
Ricordandosi di sé, divenendo cosciente della sua essenza soprannaturale divina, l’uomo come essere organico evolve non come un animale bensì tramite la coscienza. E questa coscienza per esistere non può -non deve- dimenticarsi del suo sé primitivo animale. Si parla sempre di coscienza o di consapevolezza (prendiamo pure questi due termini come sinonimi, sebbene contengano anche significati completamente autonomi e diversi tra loro), dimenticando però che per l’azione dell’essere coscienti o consapevoli esiste un soggetto, che è l’Io. Supponiamo di imbatterci nella seguente affermazione: “La parte della vita organica che si evolve è l’umanità”. Che l’evoluzione umana sia cosciente piuttosto che meccanica implica rischio e libertà. In realtà si tratta di un problema, anzi del problema: l’evoluzione cosciente è solo possibile. Può evolvere? La risposta implica una condizione, la coscienza di sè, la coscienza soggettiva. E qualora il soggetto, l’Io, divenisse -idealmente- evoluto, crescendo nell’essere, allora la sua coscienza si espanderebbe fino a divenire coscienza oggettiva permanente. Nessun uomo deve poter giungere a tanto, ma tutti devono aspirare -sempre idealmente- almeno a dei momenti di coscienza oggettiva. L’arte, tutta l’arte, è la manifestazione di questo travaglio, di questa tensione, di questa voluntas, di questa aspirazione. La coscienza, così come la volontà e l’intelligenza, è una funzione che può essere attribuita a vari esseri, non solo all’uomo, come ben sostenevano tutti gli shamani animisti sostenitori di una visione della natura come essere vivente. E come la volontà e l’intelligenza và attivata. La creatività, nel suo senso originario e tridimensionale, è l’unico strumento in grado di attivarla realmente. Il pregiudizio antropocentrico deve essere superato, non solo, ma deve cadere anche ogni forma di pregiudizio umanistico perchè purtroppo tutte le teorie intellettuali pongono l’uomo al centro di tutto. Questo è l’ostacolo principale sulla via dell’evoluzione della coscienza, l’intellettualismo inteso come comportamento disarmonico e separato dei tre “cervelli”, uno dei quali indebitamente si impossessa delle energie dei due che restano. Un seme che crea un fiore ed il suo frutto è più creativo e cosciente dell’uomo addormentato, se e quando il suo corpo e lo spirito rimangono senz’acqua, denutriti, sviliti, dimenticati. La nozione dell’Io non può prescindere dalla nozione di Dio e da quella del mondo. Vi è un nesso tra uomo, Dio e corpo fisico, che si traduce in un nesso tra psicologia, teologia e cosmologia. E l’Io è uno e trino proprio come il Dio di tutte le religioni. Così come Dio crea il mondo esteriore, l’Io crea il mondo interiore, rendendolo da caotico a ordinato, portandolo dal Caos al Cosmo. Non è sempre facile accettare una definizione dell’Io quale Signore-guardiano dell’animo umano, anche perché ci mette di fronte a serissime responsabilità… Eppure se vogliamo darci una spiegazione dell’uomo, del mondo e di Dio più accettabile di quella che potrebbero offrire la moderna psicologia, la scienza e le religioni odierne, proprio il tema religioso nel senso più profondo si colloca immediatamente al centro dell’indagine suscitando il bisogno di cercare, e quindi creare, richiamando la presenza dell’Io in rapporto a Dio, chiunque egli sia. Religere significa proprio questo: rileggere, ogni giorno. E, forse, rilegare, unire.
LE TRE FORZE
Circa le operazioni fondamentali che l’Io compie per inserirsi o per distaccarsi, in senso relativo, da questi cosiddetti corpi, esse sono l’identificazione e la disidentificazione, che costituiscono la chiave di volta per un lavoro su di sé finalizzato alla “liberazione”. La coscienza dunque o si identifica o si disidentifica rispetto ai propri contenuti. L’operazione fondamentale della coscienza è identificazione o disidentificazione. Con la prima si materializza, si fissa, si cristallizza lo spirito sui vari piani dell’energia materiale. Con la seconda si spiritualizza, si volatilizza la materia. E’ la dialettica di attaccamento-distacco, di prigionia e liberazione rappresentabile visivamente dal pugno chiuso e dal palmo aperto della mano. Il pugno afferra, la coscienza si identifica con un suo contenuto, la mano che si apre si arrende e la coscienza si disidentifica con il contenuto in precedenza acquisito interiorizzato, acquisito. Con la terza si rende tutto neutro, non è una somma, ma la stessa, unica, cosa.
Nella musica questo processo deve poter compiersi per intero, perchè quando ci si ferma alla seconda fase (o addirittura alla prima!), all’identificazione in altro da sé, si compie una sorta di tragedia del sé, l’annullamento della zona individuale che si perde e disintegra scontrandosi in esperienze individuali altre, che non sono proprie e sono potenti e affascinanti proprio perchè
centrate sulla propria unicità essenziale. Affascinano proprio perchè diverse da noi, o compementari al nostro sé più profondo, generando una sorta di matrimonio attraverso empatica autorisonanza: io capisco, comprendo l’altra essenza, dunque entro in empatia con essa (em-pathos: dentro al dolore). Ma non devo commettere l’errore di pensare di essere, essendo nell’altro da sé.
L’esperienza delle tre forze sta alla radice di tutti i sistemi antichi. La prima forza può essere chiamata attiva o positiva; la seconda passiva o negativa; la terza neutralizzante. Ma questi sono soltanto dei nomi. In realtà queste tre forze sono tutte egualmente attive; esse appaiono come attive, passive o neutralizzanti solamente nel loro punto d’incontro, cioè soltanto nel momento in cui entrano in relazione le une con le altre. Le prime due forze si lasciano più o meno comprendere, e la terza può essere qualche volta scoperta sia nel punto dell’applicazione delle forze, sia nel loro “ambiente”, sia nel loro “risultato”. In genere è difficile osservare e comprendere la terza forza, la forza equilibratrice frutto della consapevolezza nell’operare. Ma osservando se stesso, studiando le manifestazioni del proprio pensiero, della propria coscienza, della propria attività, delle proprie abitudini, dei propri desideri, ecc. (esattamente come studia quelle degli altri…), l’uomo può imparare ad osservare e a vedere in sé l’azione delle tre forze. Quello è il suo Tempo: l’intervallo tra il ricordo di sé, il passato e le tradizioni, ed il suo destino futuro che ancora non esiste: rimane solo lo spazio formato dal presente, dall’adesso.
Il suo desiderio, la sua iniziativa, sarà la forza attiva. L’inerzia di tutta la sua vita psicologica abituale che si oppone a a questa iniziativa/creativa (giudizi, retaggi, paure, confronto con l’altro da sé, compreso tutte le tradizioni), sarà la forza passiva o negativa. Le due forze si controbilanceranno, oppure l’una prevarrà sull’altra che in questo caso diverrà troppo debole per ogni azione ulteriore. Così le due forze dovranno in qualche modo girare l’una attorno all’altra, l’una assorbendo l’altra, non producendo alcun genere di risultato… La terza forza è quella che lega e (ri)unisce tutto, neutralizzando il percorso compiuto dalle prime due, producendo una dinamica propulsiva cosciente. A base di tutto vi è la consapevolezza dunque.
Quante volte nella musica si sente parlare dell’ottava come ottimale comprensione dei dodici semitoni? Noi sappiamo che sul pianoforte le sette note sono disposte secondo tasti neri e bianchi. Nell’ottava i tasti neri mancanti tra mi e fa e tra si e do indicano gli intervalli che devono essere superati se si vuole impedire la soluzione di continuità. Si può sostenere allora che ogni azione è il risultato di tre forze, invece che due come promosso dalla scienza. La terza forza è quella che occorre per riempire l’intervallo. L’adesso vitale e propulsivo. Possiamo leggerli come processi universali fondamentali, la legge dell’ottava e la legge del tre: tre sono i centri dell’Io-dio (corpo, mente e spirito); sette i livelli di creazione che sono anche livelli di vibrazione tra corpo sottile- eterico-metafisico (cioè il mondo interiore, ciò che abita il nostro corpo fisico, dunque mente e spirito) e il corpo fisico stesso, che è appunto il tempio del nostro mondo interiore. L’uomo ha sette menti, o centri, o chakra, che sono come piccoli incroci-imbuto che si innestano nei canali energetici nel punto di incrocio dei flussi. Tali livelli, strati, o cosmi, suggeriscono l’idea della scala gerarchica dell’universo con i suoi gradini in alto e in basso, lungo la quale viene trasmessa l’energia che si trasforma mano a mano che si sposta da un livello all’altro. In molte discipline si tenta di “spiegare” il raggio di Creazione, i cui sette gradini, paragonati alla scala musicale, sono identificati con i corpi celesti, luna, terra, i pianeti, il sole, le galassie, la totalità dei mondi e l’assoluto. In relazione con il proprio mondo interiore che comprende corpo eterico, corpo emotivo, corpo mentale, corpo astrale, secondo corpo eterico, corpo celestiale, e corpo causale. Chi è coscientemente creativo può sentirlo, avere la percezione di questo raggio, senza spiegarselo in alcun modo. Consapevolmente. Non c’è nulla da spiegare e che può essere spiegato.
Chi dovesse incontrare perplessità di fronte a tali argomenti non si preoccupi: non è la risposta, ma la domanda che conta. Cosa ci stiamo a fare sul pianeta? E’ sempre stato il compito degli insegnamenti religiosi quello di sviluppare la coscienza umana. Hanno sempre avuto il compito di aiutare l’uomo a compiere l’evoluzione della coscienza sulla Terra. Ma poi subentra un processo di corruzione e di decadenza provocato al loro interno da particolari tipi di individui. E’ tipico della mentalità religiosa parlare di credenza in questa o quella divinità. Ma, posto che si tratti di fede o credenza, nessuno si è mai chiesto: si può credere nell’Io? Eppure, psicologicamente, oggi più che mai appare la mancanza patologica di fiducia in se stessi. La deriva opposta, anch’essa molto diffusa e ancor più patologicamente grave e complessa è l’egotismo, che nega alcuna possibilità di armonia tra il sé ed il resto degli esseri viventi. Eppure, se non altro nel parlare, ciascuno ammette l’esistenza dell’Io, se non di Dio. Il punto di partenza dunque per la ricerca di una spiegazione del significato esistenziale è proprio questo. Se non altro nel linguaggio l’Io appartiene a tutti. L’Io non è Dio, però può diventarlo quando la sua coscienza si espande fino a diventare -idealmente- oggettiva. Non è questa una bestemmia ma il suo contrario, è solo l’affermazione di una potenzialità che ha in sé l’attualizzazione. Per rendere tale potenzialità attuale, basta superare l’inganno che consiste nel credere di essere già un Io invece che tanti io che credono in infiniti potenziali dei. L’Io non c’è e si crede tuttavia che ci sia, che sia uno invece che molti. In tale imbarazzante autoimbroglio versa la maggioranza di noi, impedita nella ricerca e nella possibilità di crescita. I cristiani, e non solo i cristiani, credono che l’anima sia già immortale. Probabilmente lo è, ed io non ho argomenti per dubitarne, ma mi piace immaginare lo sia solo potenzialmente, mi sembra sia più interessante trascorrere una manciata di anni su di un pianeta collegato ad un significato. Perchè sia immortale (in tutte le sue varie accezioni) il nostro compito terreno è attivarla e farle compiere dei passi. L’arte, in quanto espressione del sé, è lo specchio di ciò, è come un registratore sempre acceso della nostra esperienza, una telecamera sempre vigile dei nostri movimenti, della nostra volontà di fare, di creare, di lasciare tracce oggettive dei nostri soggetti. Non può e non deve essere solo l’urlo capriccioso e disperato dei nostri tanti piccoli ego. Poniamo attenzione su questo: la musica naturalmente contiene una natura di divertimento, di rappresentazione, di intrattenimento. La musica è persino anche spettacolo. L’arte in genere, dunque non solo la musica, ha bisogno invece di proteggere e coltivare il suo significato di ricerca ed attivazione dell’Io individuale, dunque la sua zona creativa, senza la quale rimane solo espressione limitata -quando non svilita- di individui limitati -quando non sviliti ed incompiuti-. Non voglio essere equivocato: quando dico limitati non mi riferisco ai difetti o ai limiti umani, che invece sono necessari in quanto chiave, carburante propulsivo della ricerca, del desiderio e della volontà di espansione. Uso la parola limitati letteralmente, perchè di fatto producono un’espressione parziale bloccata da mille fattori e incognite, in quanto delle zone fondamentali del sé non sono presenti o, se presenti, non sono attive. Se non fosse che il parallelo con un’arte, una musica addormentata è indubbiamente inefficace dovrei proprio usare la parola addormentati perchè mi riferisco direttamente al sonno in-cosciente dell’Io.
La ricerca musicale, quando collegata alla zona creativa dell’essere è certamente è un potentissimo strumento di risveglio, attiva e auspicabilmente (ri)trova l’Io e, soprattutto, non smette mai di cercare Dio dentro di sé, e non fuori da sé, superando i tanti dei che incontriamo lungo il percorso, nell’incontro con le tradizioni e nel coltivare le legittime, ma talvolta passeggere, passioni. E mi premeva osservare l’analogia “in scala” tra Dio e Io per sottolineare la necessità di risvegliare quel senso di responsabilità che spesso è ingiustificato assente, o in qualche caso addirittura inesistente. La musica, e in particolare la prassi dell’improvvisazione, può servire inoltre a tenerci sempre svegli nell’istante-presente e a sviluppare col passare del tempo l’essere dell’Io in contrapposizione all’apparenza dei vari gruppi di io.
L’Io è permanente, l’io è mutevole: la vera rivelazione potrebbe essere convincersi che l’Io è uno e trino, dotato di tre funzioni che sono presenti l’una nell’altra. Se tutti i credenti delle varie religioni esistenti oggi sul pianeta facessero questo ragionamento capirebbero certo il nesso Io-Dio e avrebbero un motivo per smetterla di perseguitarsi a vicenda! Ma la coscienza facilmente dorme per l’uomo contemporaneo, almeno fino a che non viene risvegliata. L’uomo è avvolto nel sonno della sua coscienza. Chiediamoci: come va inteso il sonno della coscienza? Tale è la condizione dell’uomo di oggi, l’uomo macchina, l’uomo che vive la meccanicità, la routine, la ripetizione, la rappresentazione, l’imitazione. Cerchiamo la macchina, la meccanicità? Una macchina non può accendersi e partire da sola. Così l’uomo non ha una vera volontà e iniziativa, ne ha tante a seconda delle circostanze. In ultima analisi sono le circostanze esterne che lo dirigono, sotto la forma di influenze esterne. Così l’uomo che vive al livello della coscienza dorme, nel senso che non si accorge della subcoscienza (autoaffermazione dell’ego e delle varie piccole personalità) e non la integra nella coscienza di veglia, attivando al livello superiore della conoscenza di sé tramite il triplice sforzo del ricordo di sé. Avviare la macchina significa risvegliarsi alla realtà inconscia dell’Io triunitario dotato di tre cervelli e crescere fino a quello che viene detto l’uomo bilanciato. Nutrimento cosciente, sesso cosciente, affermazione dell’Io sui vari io: l’inizio di questo processo di risveglio sta nella consapevolezza del proprio sonno, della propria impotenza e limitatezza.
Il pensiero di Dio non può essere limitato, ad esempio, al solo spirito, dunque disgiunto dall’Io- pensiero e dall’Io-corpo. Il concetto è immutabile anche se interscambiamo le tre orbite dello stesso universo.
MUSICA E COSCIENZA
La ricerca musicale ci insegna che non esiste suono cosciente se non siamo quel suono, se non diventiamo quel suono ogni volta come se nascesse lì in quel momento, divenendo Dio di quel suono e veicolando il sé, la nostra parte divina. L’inizio del processo che conduce ad una concezione unitaria avviene nel momento in cui l’individuo usa la propria consapevolezza per cogliere il triplice nesso, e dunque prima o poi arriva a chiedersi cosa ci sta a fare qui sul pianeta Terra accanto alle piante e agli animali, agli elementi chimici, ai sassi e alle pietre, all’acqua e all’aria.
Ma cos’è questa coscienza che continuo ad evocare? Cos’è, come si chiama quella zona che consente alla rondine di uscire dal nido e volteggiare sfruttando le correnti d’aria senza dover studiare la dinamica, la gravità, le forze, e compiere esercizi di anni. Cos’è, come si chiama questa parte evoluta dell’istinto? Possiamo chiamarla coscienza? O corpo atmico? E’ una parte della mente, dello spirito o del corpo? O forse di tutti e tre i centri contemporaneamente?
Un giorno nell’antica Grecia, circa 500 anni prima di Cristo, i sette Savi andarono a Delfi e il gran sacerdote approfittò per far scrivere ad ognuno di essi una massima sulle mura del tempio, e a Chilone non veniva in mente nulla: le frasi migliori le avevano già scritte gli altri. Stava per rinunciare quando prima di andarsene butto lì, proprio sul frontone d’ingresso una frase che risuonerà sino ad oggi: “Conosci te stesso”.
Se chiediamo a noi stessi cosa significa coscienza, così viva e presente è la sensazione di esserci dentro, noi così pieni di idee, di emozioni e soprattutto di volizioni. Volizione è una parola bellissima, che nasce da volitivo, termine designante l’atto della volontà, il processo nel quale essa si manifesta. Per Cartesio è proprio il dubbio, la domanda, la prova essenziale di essere coscienti. Dunque ci si ferma a destinarle parole come mistero, illusione, esplorazione, ecc, e la storia di coloro che si sono occupati del problema è lunghissima, dalla preistoria percorrendo tutta la filosofia. Io non sono un filosofo, beninteso, ma un musicista che vuole raccontare cos’è stata e cos’è la musica per la mia esistenza attraverso una prassi, cioè l‘esperienza pratica quotidiana, e non attraverso ideologie o principi teorici. Per questo sfioro solo argomenti che mettono i brividi e meriterebbero in sé riflessioni ben più dotte e profonde, saggi e trattati.
Si è provato a trattare il problema dal punto di vista scientifico, con un approccio di tipo riduzionista, materialista, o eliminativista, o comportamentista, che sembrano sempre un poco insoddisfacenti perchè non solo non tengono conto dello spirito, ma superano il dualismo mente corpo, risolvendolo come un argomento della scienza naturale, dunque della fisica.
Questo ha scatenato una reazione opposta, naturalmente sovrastrutturata a sua volta e talvolta esagerata: la metafisica, la teoria delle complessità, la fenomenologia, persino un ritorno all’esoterismo. Di fatto, ancor oggi si passa dalle teorie vaghe e sperimentabili della metacognizione e dell’introspezione, sino all’opposto, con le teorie degli ingegneri neurali che guardano con più interesse al silicio e ai circuiti integrati dei computer, in ottica di giungere ad una piena comprensione del funzionamento fisico/neurale del cervello.
Nella mia piccola esperienza di musicista che si occupa di improvvisazione sia da un punto di vista espressivo/artistico sia da un punto di vista pedagogico/sperimentale e metodologico/didattico posso dire, senza rischiare di essere banale, che l’esperienza musicale non raggiunge mai coscienza sino a quando le tre forze non sono attivate e i tre centri non sono armonizzati tra loro. E che per diventare una esperienza totalizzante la musica ha bisogno della presenza simultanea della mente, del corpo e dello spirito del suo esecutore-creatore-performer, e proprio come l’individuo ha bisogno in sé di avere un corpo, una mente ed uno spirito. Se quattro musicisti suonano senza una guida fuori da sé, come può essere uno spartito, all’inizio regna l’insicurezza, l’indecisione e la confusione. Poi lentamente ognuno comincia a prestare ascolto a sé e quindi, ancor più difficile, agli altri strumenti ed infine si giunge persino ad una coerenza collettiva, che presuppone una coscienza collettiva e dunque quattro coscienze individuali in dialogo/osmosi. Allo stesso tempo accade di frequente che lo spartito, la guida fuori da sè, si sostituisca tout court al performer, il quale affida completamente ad esso lo spazio del sé, come fosse un riempitore del suo vuoto di coscienza, o di creatività, o di responsabilità.
Ebbene, il comune denominatore di tutte queste esperienze ci rivela infine il significato di coscienza: la coscienza è un processo, e un processo dinamico, non un oggetto fermo. Dunque il risultato dinamico, appunto, delle attività distribuite in modo armonizzato dei tre centri dell’uomo (o dalle tante popolazioni di neuroni organizzati che abitano le diverse aree del cervello, direbbero i riduzionisti…).
Questo processo, che in sé è di natura centripeta perchè diretto verso il proprio mondo interiore, è in assoluto assai più compiuto e nutriente se vissuto in un senso centrifugo, cioè di spinta sprigionata verso l’esterno, verso l’oltre, o l’altro; dove per altro si intende tutto ciò altro da noi, compreso il Cosmo con la C maiuscola, anche fosse un luogo del tutto ideale, infinito, confutabile e imperscrutabile come probabilmente è. In particolare in musica letteralmente si incarna nel suono come in una straordinaria metamorfosi. Così almeno urliamo dentro questo infinito che stiamo facendo la nostra parte, il nostro lavoro, e soprattutto superando l’equivoco -la vecchia storia che si ripete nella nostra cultura- che ci porta a fare solo se spinti dall’esigenza di provare stima di sé, ponendoci al centro di tutto, esattamente come nell’antichità vi fu l’esigenza di credere che l’uomo fosse al centro del cosmo e la Terra fosse al centro dell’universo, auto-eleggendoci egoticamente come eletti tra gli eletti.
Londra 2018
William Ward – Quanto incide la sua “italianità“ nella sua arte – e nel caso, le sue precise origini milanesi – rispetto alla sua produzione musicale, che ha un respiro ampio e universale?
Stefano Battaglia – L’appartenenza non è una questione di stile, o di geografia, deve essere qualcosa di più profondo.
L’identità è la somma delle verità individuali con le volontà e i desideri: ciò che si è con quello che si vuol essere.
La mià italianità non è una volontà, è un fatto. Una verità. Non ho alcuna possibilità di intervento su questo. Devo accettarlo. Gioiosamente.
Quello di cui posso occuparmi invece è la voluntas, i miei desideri e le mie volontà, che devono essere in armonia con le verità. Solo quando esiste armonia tra queste due aspetti dell’essere si crea il presupposto potenziale dell’espressione profonda.
L’errore sta nel considerare l’arte solo come logos, linguaggio: La musica non è un linguaggio, ma un meta-linguaggio. Non c’è solo grammatica e sintassi, c’è una zona misteriosa che và protetta, e che è la somma delle verità individuali di chi la propone.
Non è triste quando vediamo il pigmeo con il naso alla francese, o l’orientale con gli occhi all’europea? Lo stesso nell’arte: quando ascoltiamo un coreano cantare un blues del delta del Mississippi o un africano suonare le Variazioni Goldberg sentiamo solo il linguaggio, l’idioma. Ma non può esserci appartenenza profonda, comprensione totalizzante. Ed è giusto così, perchè questo rende necessario viaggiare per ascoltare la musica dei popoli, oppure far viaggiare gli artisti perchè giungano in altre civiltà a fare ascoltare la loro verità più profonda.
L’Inghilterra è un esempio paradigmatico: il teatro elisabettiano inventa la canzone, e da allora è il luogo metafisico dove quel seme genera nuovi rami, nuove foglie e nuovi frutti, attraverso gli inni, le lodi, le arie: John Dowland, William Byrd, Thomas Morley, Orlando Gibbons. Io sento tutta quella forza creativa 500 anni dopo in Peter Gabriel e Thom Yorke: sento la stessa linfa che passa da Hogarth a Reynolds a Turner, attraverso Purcell sino ai Genesis passando per T.S. Eliot, da Burke a Benjamin Britten, da Blake a Peter Hammil o Scott Walker.
Questo è il senso dell’identità.
W.W. – Sono 25 anni che non si esibisce in Inghilterra, tanti: qualche motivo x la lunga attesa del suo ritorno a Londra? Quali aspettative ha di questa prossima tappa londinese?
S. B. – Sono privilegiato: suono in tutto il mondo la mia musica, come compositore e performer. Non riesco a concentrarmi sul motivo per cui corre così tanto silenzio nella relazione tra me e un paese così ricco di tradizione musicale come l’Inghilterra. Le cose vanno sempre come devono andare.
E’ normale non suonare sempre ovunque, ed è normale anche non “piacere a tutti”: quando c’è consenso totalizzante, nell’arte, è sospetto e bisogna cominciare a preoccuparsi.
Immagino, come è normale, che nessuno in Inghilterra in questi anni abbia avuto interesse in quello che sto facendo. La mia determinata assenza e protezione dai social media ha certamente un prezzo da pagare che sono disposto tranquillamente ad accettare. Gli ultimi concerti londinesi risalgono a quasi trent’anni fa e sono stati voluti da un grande batterista inglese come Tony Oxley, con il quale avevamo vinto un premio per l’album in duo “Explore”. Avevo
vent’anni, tornarci ora con una consapevolezza diversa sarò una gioia immensa: un privilegio che si somma ad una vita privilegiata!
W. W. – Sono ormai sette gli album che ha inciso per la ECM: data la sua particolare sensibilita’ per certi temi diciamo politici, come ha sempre reconciliato il suo impegno “politico” con il loro ethos notoriamente “estetico”?
S. B. – Da quando la politica è diventata unicamente strumento di “gestione dell’economia” non sono affatto interessato alle vicende politiche, non riescono a coinvolgermi, mi annoiano e deprimono.
Quello che invece mi appassiona è l’ethos, come fattore di principio del vivere, elemento fondante dei valori dell’umanesimo, in un senso trasversale, universale direi.
La piattaforma ECM è spesso equivocata come un manifesto “estetico”, mentre personalmente la leggo come un manifesto “etico”, di principio trans-culturale. Il principo ideale, unico al mondo per quanto concerne le piattaforme discografiche, che sostiene che in musica non esiste ideologia, nè razze nè religioni: ECM è l’unico catalogo che veicola musica antica e contemporanea, classica e barocca, folk e tradizionale, mainstream jazz e free jazz, nuove musiche e elettronica, concentrandosi unicamente ad un’ideale di bellezza, dando voce a tutte le regioni del pianeta, con le loro specifiche, differenti caratteristiche identitarie.
L’unica scelta estetica, semmai, è quella legata alla ripresa del suono, ma non mi sembra sia l’aspetto più importante ed interessante. Per prima cosa c’è questo giardino selvatico pieno di fiori diversi, di tutti i colori e grandezze, che stanno armoniosamente uno accanto all’altro. Nello stesso spazio. E’ molto di più che un catalogo: è una filosofia che sposo completamente, un manifesto di dialogo-attraverso-la-bellezza per il quale provo riconoscenza, complicità, empatia, adesione e condivisione. Sia come fruitore che come performer.
W. W. – Che cosa ci puo’ raccontare delle sue ispirazioni e dei suoi spunti creative che ha versato nel suo ultimo album “Pelagos”?
Percepisco il rischio di chiudermi in una bolla magica, separato dal resto dell’umanità, a fare l’artista con la testa tra le mani. Il mio ruolo sul pianeta qual’è? Non posso solo occuparmi di suonare bene uno strumento. Devo cercare di poter dire qualcosa di utile alla memoria di questo pianeta. In certi momenti è irritante che l’arte dimentichi di dove siamo, della realtà presente, e si ostini ad auto-celebrare sè stessa, con omaggi a Vivaldi e Frank Zappa, a Chopin e a Jimi Hendrix, intanto che la gente muore nelle guerre civili, o alla ricerca di una possibile esistenza sostenibile. Cinque anni fa preparavo un ciclopico omaggio alla figura di Alec Wilder e mi sono sentito un pò stupido a stare settimane intere chiuso nel mio studio a lavorare ad una cosa che era completamente legata alla mia propria ricerca, ma che non aveva alcun senso di collegamento con il reale. Cosa sto facendo? A chi interessa? A chi posso essere utile?
Ecco l’ethos, il principio.
Quello che sta accadendo nel Mediterraneo mi distrugge. Una volta era il mare dello scambio virtuoso, gli ori e le spezie, la musica e la danza, la seta e la frutta. Napoli, Venezia, Genova e la Sicilia. I porti erano approdi vitali. Da qualche anno è tornato ad essere un sepolcro, come nelle omeriche odissee.
W. W. – Ci racconta come ha conosciuto Bejan Matur e che cosa le ha convinto di dover collaborare con lei in questo spettacolo?
S. B. – Io amo la poesia, da sempre. Ho bisogno di poesia, in ogni cosa. Aspiro ad essere un poeta, con tutto me stesso, anche se il mio strumento non è la parola.Ho incontrato Bejan ad un festival di poesia nel cuore montuoso della Sardegna. Non conoscevo la sua poesia. Quando l’ho ascoltata poetare in curdo mi sono commosso, pur non capendo una parola di curdo! Passa tutta la forza, tutto il dolore, tutta la nostalgia, tutta la speranza, tutta la rabbia! Quindi sono andato a ringraziarla e con mia grande sorpresa lei mi ha confessato commossa di ascoltare sempre la mia musica, da anni. Conosceva e amava i miei dischi…non è incredibile? Quando accadono queste cose appare evidente che esiste un destino che governa e pilota tutto, facendo succedere le cose giuste al momento giusto. Ogni volta che ho fatto concerti a Istanbul sento tutto il senso potente della musica come possibile comunione, compassione, metalinguaggio. Inoltre Bejan è curda, ed il suo popolo rischia una “questione” simile a quella armena, per molti aspetti. Ecco, attarverso l’arte abbiamo credo il dovere di dire sempre agli sradicati, a tutti gli uomini: io sono qui. Non sono la politica, dunque non posso darti un permesso di soggiorno, ma posso dire attraverso la poesia e la musica che siamo svegli e abitiamo la stessa casa, che è questo pianeta. Dove tutti in partenza abbiamo gli stessi diritti, e dobbiamo lottare insieme per questo.
W. W. – Perche’ ha deciso di fondere degli elementi “forti” della poesia e del Jazz, per raccontare la sua narrazione del Mediterraneo, e della recente crisi dei migranti che lo attraversano in imbarcazioni molto precari, ad alto rischio?
S. B. – L’arte deve tornare ad avere un ruolo attivo, propulsivo nella vita sociale. Non può essere solo un intrattenimento. E’ una memoria diversa da quella della storia, la potremmo definire una meta-memoria. La forza devastante della Guernica di Picasso racconta del bombardamento nazista e fascista meglio di qualunque descrizione storica. Perchè è l’espressione del dolore e dell’ingiustizia, non una semplice somma di nomi e date, di colpevoli e innocenti. Il fatto che anche tra mille anni, guardando quel dipinto, la gente riesca a “provare” il dolore e l’ingiustizia, a sentirlo, rende un’opera artistica utile alla coscienza dell’uomo, e alla sua espansione percettiva, spirituale ed intellettuale.
L’improvvisazione ci dice “hic et nunc”, qui ed ora! Ed il Mediterraneo offre il privilegio di mettere in musica questo dialogo tra diversità, utilizzando i diversi linguaggi che la sua cultura profonda contiene intrinsecamente, come una Grande Culla.
W. W. – Perche’ il “Mare Nostrum” e’ un ispirazione cosi forte nella sua creativita’ – e anche in quella di Bejan – quando in fondo c’e’ tutta l’infinita ricchezza della cultura milanese, e se vogliamo, del Po – che e’ stato “la muse” di tanti artisti, poeti e cineaste italiani in passato?
S. B. – Il Mare Nostrum è il simbolo di tutte le civiltà del bacino mediterraneo, non è “nostro” in un senso strettamente italiano, anche se in un recente passato pseudo-imperialista abbiamo tristemente evocato questo preteso possesso che ci deriva dal romano impero, ma che naturalmente non esiste.
Il Po invece è un fiume “esclusivamente” italiano, non è manifesto di dialogo tra civiltà: diviene simbolo di dialogo solo quando le sue acque sfociano nell’Adriatico, nel Mare Nostrum, mischiandosi a quelle dei fiumi dei Balcani e del Peloponneso, a quelle turche e siriane, del Libano e dell’Egitto, di Israele e della Palestina, della Libia e dell’Algeria, della Tunisia e del Marocco, risalendo alla Spagna e alla Francia.
Questo mosaico di incrdedibile ricchezza è la civiltà alla quale sento di appartenere, ben sapendo che la mia cultura mittleuropea, quella di Bach e Haendel, di Haydn e Beethoven è
presente in egual misura. E’ proprio il dialogo tra la civiltà musicale mittleuropea e quelle turche-ottomane, arabo-andaluse, balcaniche e caucasiche il contributo più stimolante alla creatività di chi vive al centro di questi luoghi.
W. W. – L’Italia si e’ lanciata in una campagna elettorale che si prospetta ancora piu’ confusionaria, con delle eventuali risultati molto incerte: quale risultato teme di piu’?
S. B. – Come ho detto la politica non riesce a coinvolgermi già da molti anni perchè le ragioni economiche prevalgono su quelle culturali e sociali e perciò abbiamo una gestione governativa per lo più pilotata da alta e bassa finanza, che alla fine sono la stessa cosa. Si fatica addirittura a riconoscere talvolta le differenze tra gestione mafiosa e gestione governativa, dato che la corruzione è da secoli un fenomeno ampiamente storicizzato e cristallizzato, con un livello di rassegnata accettazione talvolta davvero insopportabile. La preoccupazione è che la deriva culturale mantenga il paese nello stato di sonno permanente in cui versa da quasi trentanni. Quando il tessuto sociale è addormentato automaticamente aumenta il degrado e la corruzione e questo innesca ulteriore impoverimento delle possibilità di investimento nell’istruzione e nella cultura, che sono gli unici strumenti di risalita per qualsiasi civiltà. E’ la storia che ce lo insegna, eppure il conflitto tra l’uomo e la sua memoria permane proprio perchè senza cultura non c’è memoria: l’arte e la cultura sono la memoria di ogni civiltà. Senza cultura non si rinnovano le tradizioni e non si da il giusto valore a quelle del passato, è come se cancellassimo il nostro hard disk svendendolo in cambio di piccoli poteri. Perchè i soldi sono un piccolo potere, in un senso filosofico e umanistico. Quello che l’Italia si ostina a non capire è che la cultura è il seme. Da quello si determinano le radici e si da lì la linfa vitale per arrivare attraverso il tronco su su sino alle ultime foglie. L’albero non si dimentica di questo circuito.
W. W. – Da diversi decenni, la sua patria versa in una profonda crisi di creativita’ in quasi tutti I settori della cultura e dello spettacolo: di idee, di energie, e anche di soldi – una crisi strutturale a tutto spiano. In genere una crisi di questa portata in un paese importante crea delle premesse per una fioritura artistica importante. Perche’ non e’ stato cosi in Italia? O non e’ del mio parere?
S. B. – Hai detto la parola chiave: la creatività. La creatività è un muscolo, e come tale andrebbe “allenata”. Non credo che ci siano assenze di idee e di genio creativo. Credo però che si sia spostato altrove la richiesta di creatività: non più musica, danza o poesia ma numeri. Siamo divenuti una civiltà di numeri, la tecnologia digitale ci ha portato in una direzione per la quale lì la creatività è “utile”, rendendo automaticamente “inutile” e “surplus” l’espressione profonda del sè individuale, che è l’arte (la musica, la poesia, la danza, ecc). Credo che sia ancora una volta un problema di civiltà occidentale in genere, non esclusivamente italiana. E credo che alla base del problema vi sia il “ricatto” del benessere. L’arte ha bisogno di urgenza espressiva, di cose da dire. Quanto tempo passiamo nel dolore? Quale pathos può veicolare una civiltà che si difende dal dolore? Una civiltà che addirittura si difende dalla vita, perchè preferisce passare la sua esistenza davanti a dei computer (che sono un alias della vita, una rappresentazione digitale della vita) piuttosto che fare un viaggio o anche solo una camminata di un paio d’ore! Generalmente l’individuo ora si arrabbia se non trova parcheggio sotto casa, o sotto l’ufficio! E poi investe i suoi denari per trascorre del tempo in palestra, quando invece andando a piedi a lavorare farebbe due cose in una… Quanto tempo passiamo a contatto con altri animali liberi, quanto tempo passiamo nel silenzio e nel pericolo della natura? La natura che ci offriamo è una natura organizzata, addolcita, accomodata. Quando per così tanti anni sembra che l’unico valore da inseguire sia il benessere economico è difficile che si determini urgenza espressiva potente: cosa abbiamo da dire, come civiltà del benessere? Quanto tempo passiamo nel dolore? Io non
sento di appartenere a questa civiltà, in un senso filosofico. Appartengo per geografia, è la mia realtà. Ma giudico le scelte fatte dall’illuminismo in poi delle scelte sbagliata, con il senno di poi: pensare che il benessere individuale passi dalla ricchezza economica è un corto circuito decadente.
Tempo
Ci racconti di Manfred Eicher che sedutosi per ascoltare gli speakers Uvola se ne è andato via con i vostri nastri?
Certo, credo sia stimolante per chiunque sapere che i sogni, se perseguiti con forza e rigore, possano realizzarsi in realtà. Ed è ancora più bello se tutto ciò avviene secondo delle logiche e dei contenuti di assoluta purezza, dove cioè, nello specifico, nè io nè Manfred Eicher “forziamo” in qualche modo perchè la favola si realizzi: Manfred ha ascoltato la mia musica quasi casualmente, durante il mix del disco del quintetto di Rava a Cavalicco (Udine), lo studio di Stefano Amerio. Amerio che aveva registrato i miei nastri in trio durante quel periodo e che ha pensato di far ascoltare a Manfred alcuse cose tratte da quelle session. Manfred ascoltandoli ha evidentemente pensato che avrebbero dovuto essere dischi ECM, e così è stato! In seguito mi ha confessato che si è trattato della prima volta in assoluto che ECM produce un lavoro non pensato, progettato e seguito da lui in prima persona, ma ha sentito subito vicina quella musica come se fosse stato lì con noi ad eseguirla.
Fare musica è la tua professione: sei però d’accordo nel dire che registrare per ECM sia prima di tutto un privilegio?
Privilegio enorme, ma anche frutto di una feroce “protezione” di ciò che faccio, che non è proprio quello che si dice una musica “furba” o ossessionata dall’idea di “essere sul mercato”.
Perchè il titolo Raccolto?
Raccolto significa diverse cose, tutte molto vicine al significato che ha per me questo lavoro discografico: questo disco è per me un raccolto, una personale messe, lo considero anche un grande riconoscimento a quello che fino ad ora ho cercato di costruire.
Ed è è anche un buon aggettivo che descrive il mio universo musicale, concentrato sullo sviluppo e l’espansione “dall’interno, senza ideologie musicali o modelli di riferimento esterni al processo creativo. Processo creativo che nell’improvvisazione (l’album è sostanzialmente una raccolta di improvvisazioni estemporanee) assomiglia proprio ad una “raccolta”, ad una messe, dove tu ti fai strumento di qualcosa di unico che si genera in quel preciso istante: è come se la musica ti regalasse attraverso la sua voce, il suono, i suoi meravigliosi frutti e tu, durante l’azione musicale, non devi far altro che renderti disponibile a raccoglierli, accogliendone i contenuti e provando a modellarne le forme.
Riprendo un discorso molto interessante tirato fuori nella conferenza stampa: per un artista quanto è importante proteggere la propria creatività? Mi spiego: quanto questo è importante in un’epoca in cui tutto invoglia il contrario perchè tende all’iperattività?
Come ho detto prima il “raccoglimento” è la mia condizione ideale. Per me la musica è esistenziale come la preghiera per il monaco, non c’è descrizione più pertinente. Ha a che fare con ciò che per me è sacro e con il senso del sacro che si è sviluppato in me durante tutti questi anni indipendentemente da una mia volontà precisa. E dunque implicito che è dentro di me che “raccolgo” forze ed energie e il territorio che più mi attrae della musica è la manifestazione e non la rappresentazione, che invece è proprio ciò che interessa
generalmente al mercato. Se dunque mi riferissi “all’esterno” per motivare la mia ricerca di musicista avrei già smesso da tempo, e che mi sta vicino sa che sono stato vicino all’abbandono più volte, negli ultimi tempi. Avrei continuato a suonare solo per nutrirmi interiormente, come è di fatto da sempre e per sempre sarà, ma abbandonando però l’idea di riferirmi al mercato della musica come mezzo di sostentamento, accantonando definitivamente un’idea di professionismo che spesso mal sopporta una dimensione puramente artistica. Non ho alcun interesse per le novità, le riviste “specializzate”, le mode, le parole d’ordine ideologiche del nostro circuito: generalizzando e salvo casi sporadici l’opinione della critica musicale in genere è per me imbarazzante e dolorosa allo stesso tempo: imbarazzante per la penosa dipendenza da fattori extra-musicali e bassi contenuti, dolorosa perchè si occupa di qualcosa che per me, come dicevo è esistenziale, mentre per “l’operatore” è per lo più un mestiere o, al meglio, una semplice passione. Ma non è la lamentela dell’incompreso, beninteso, l’imbarazzo e la delusione esistono anche quando si parla di me come un genio: è sempre il COME e il PERCHE ciò avviene che lasciano il segno.
Mi parli della visione dei due trio? In cosa sono diversi ed in cosa uguali?
Il comune denominatore dei due trio è la ricerca nell’improvvisazione “tabula rasa”, una ricerca che và più nella direzione della composizione istantanea che non nella dimensione liberatoria del processo musicale, in una direzione quasi opposta all “suonare sopra qualcosa”, tipico della prassi tradizionale jazzistica, sia mainstream che “free” o altro. C’è più la volontà di creare una forma dal nulla che abbia intrinsecamente le stesse qualità e rigore della composizione, a volte con degli sviluppi, altre senza alcuno sviluppo, accontentandosi di aver creato un “contenitore” sufficientemente grande ed esteticamente stimolante ma senza l’ossessione di riempirlo a tutti costi. Le differenze tra i gruppi sono invece nei linguaggi utilizzati: il primo è una combinazione tipicamente di tradizione jazzistica (piano contrabbasso e batteria) e ai linguaggi di emanazione jazzistica è evidentemente legato.
L’altro è un trio più collegabile a certe formazioni cameristiche contemporanee ed evidentemente ai linguaggi della musica colta del novecento deve gli ingredienti delle sue improvvisazioni. Il set di Michele Rabbia, ad esempio è molto diverso nelle due formazioni, e le sonorità sono decisamente differenziate. Vi sono anche dei brani in cui utilizzo il piano preparato così come suggerito e descritto nel Totem ancestors o Music of changes di Cage. E anche questo fa parte del raccolto: la musica classica e il jazz sono le mie due grandi passioni, i due linguaggi di riferimento, e la loro condivisione è sempre stata nella mia vita musicale esplicitamente tormentata, tanto da confondere spesso chi mi seguiva in una o nell’altra “direzione”: In questo album sono “raccolte” entrambe le esperienze.
Il tuo prossimo progetto orbiterà sull’arte cinematografica di Pasolini. Qual’è la valvola di passaggio per mettere in comunione la tua musica con il suo cinema? E per quando è prevista l’uscita dell’album?
E’ un’opera celebrativa più complessa e completa, spero, non il semplice frutto della combustione tra la sua opera cinematografica e la mia musica. Ho scritto quasi quaranta composizioni, alcune derivate dalla sua opera poetica, altre ispirate alla saggistica, altre ancora al teatro. Poi ci sono brani dedicati alle figure decisive attorno alla sua esistenza
(Moravia, Elsa Morante, la Callas, Anna Magnani, Laura Betti). Ci sono due Requiem (Ostia e Pietra lata), poi ci sono i brani tratti dal cinema “popolare” (Accattone, Mamma Roma) e quello di ricerca (Il Vangelo, Medea). E’ il tentativo di esprimere attraverso la musica quei contenuti che Pasolini riusciva inesorabilmente a comunicare attraverso canali espressivi così diversi, e attraverso linguaggi (quello colto e quello popolare) apparentemente molto distanti tra loro. Così apparentemente distanti da creare perversa attrazione e anche confusione attorno a sè. L’evidente tormento di Pasolini nel far coesistere questi linguaggi così diversi, sostenuti da comuni denominatori sempre uguali a sè stessi e, se possibile, sempre più forti nel tempo, è complicità da me condivisa e dunque la scintilla, la ragion d’essere del mio “ciclopico” lavoro attorno alla sua figura. Figura del cui spessore, ideologie a parte, se ne sente fortissima la mancanza, al di là di tutto. Tutta l’opera è stata registrata in tre fasi diverse e da altrettante diverse formazioni: la parte costruita sui linguaggi di dervazione classica contemporanea è un quintetto con Dominique Pifarely al violino, Vincent Cuortois al violoncello, Bruno Chevillon al contrabbasso e Michele Rabbia alle percussioni. La parte più popolare, con i brani di estrazione cinematografica o dedicati al suo periodo friulano e giovanile è stata suonata da un quintetto con due sassofonisti tenori (Francesco Bearzatti e Dan Kinzelmann), Giovanni Maier al contrabbasso e Emanuele Maniscalco alla batteria. Il possibile “ponte” tra questi due mondi è “incarnato” da un sestetto composto da Michael Gassmann alla tromba, Mirco Mariottini ai clarinetti, Aya Shimura al violoncello, Salvatore Maiore al contrabbasso e Roberto Dani alla batteria. La prima parte del missaggio avverrà ora, a fine mese, l’uscita presumo una decina di mesi a seguire.
Dialoghi I
1. Com’è entrato il jazz nella tua vita e quali sono stati gli artisti di riferimento per la tua formazione?
Un processo naturale, credo tipico del pianista (un poco ossessivamente) concentrato sullo studio già ad una età infantile, dai sei anni, ascoltavo per inerzia quasi esclusivamente musica classica e le varie interpretazioni dei brani che studiavo; e il rock che ne era palesemente influenzato, specie il progressive inglese. Ero un grande fan dei primi Genesis, di cui cercavo di replicare a orecchio le parti di piano, come il preludio di Firth on Fifth, che ricordo essere stato il primo brano extra-classico ad aver suonato. Come noto in quel linguaggio c’era un alto livello di sperimentazione e di contaminazione dei linguaggi, tra cui il jazz (specie nei King Crimson e nei Gentle Giant, ma anche negli Emerson Lake and Palmer).
In sintesi combinai queste due passioni (il piano e le nuove musiche contaminate) e nel 1979, in uno dei tanti sabati trascorsi dentro Buscemi dischi, il mio abituale fornitore di dischi a Milano, osai l’acquisto a scatola chiusa di due dischi per solo pianoforte. Non sapevo nulla di quei pianisti, tanto meno della musica che vi poteva essere dentro. Mi intrigavano in sé, in quanto musica altra eseguita al piano, lo strumento che riempiva le mie giornate di studente, ma non scritta, non di tradizione e/o di repertorio. Mi imbattei in due capolavori degli anni settanta: Facing you di Keith Jarrett e Open to love di Paul Bley.
Decisamente mi cambiarono la vita. Col senno di poi ringrazio sempre il mio istinto (ed ECM!): sono ancora oggi due tra i miei dischi preferiti, e non sol,o per ragioni romantiche. Da lì, a ritroso, è naturale cercare di capire da dove diavolo arrivasse quel linguaggio, e dunque giungere attraverso Jarrett a Miles e attraverso Bley a Ornette Coleman e alla stagione creativa degli anni sessanta. E Miles ti fa giungere a…tutto, è lui l’arteria “giusta!”: Bill Evans, Coltrane, Shorter, Cannonball, Mingus, Horace Silver, Tristano, Lee Konitz, Parker. Miles incarna davvero il grande fiume! Tu lo navighi e lui sembra indicarti gli affluenti giusti a cui dedicarti e nella cui esplorazione abbandonarti.
2. A differenza di altri generi musicali, il jazz, anche per la peculiarità delle sue origini, strettamente collegate a fenomeni sociali quali l’emigrazione e l’emancipazione della condizione personale, racchiude nel proprio codice linguistico la capacità di esprimere valori universali, tanto che talvolta si parla di “una filosofia jazz”. Il dialogo, la capacità di ascolto, l’integrazione, in generale l’aspirazione alla libertà sembrano essere alla base di un modo di intendere la vita, che si manifesta in musica. Pensi che la musica possa essere un veicolo efficace per l’espressione di questi valori ?
Non c’è dubbio. La musica non è un linguaggio, ma un metalinguaggio. Il metalinguaggio, a differenza del linguaggio, determina un ideale territorio comune, direi addirittura una comunità, di individui/anime/spiriti assai diversi tra loro per linguaggio, cultura, tradizione, stato sociale, razza e religione: è uno spazio privilegiato per l’incontro, il dialogo, la comprensione, la compassione, l’empatia. Io attraverso la visione di Guernica riesco a entrare nel dolore (em- pathos!) degli abitanti della cittadina basca. Non è semplice conoscenza, o traduzione intellettuale: è comprensione profonda (cum- prehendo, cioè afferro le cose dinanzi a me nel loro insieme): l’arte mi porta lì con loro anche senza essere di quella regione del mondo, di quella cultura e senza subire fisicamente il bombardamento tedesco; così come un solo di Parker mi racconta dell’autoaffermazione del popolo afroamericano nell’America del dopoguerra. Non c’è politica, non c’è religione, c’è il grande libro della storia dell’uomo attraverso l’espressione sublime delle loro menti, dei loro corpi e dei loro spiriti! L’errore più comune è quello di cercare di comprendere l’arte esclusivamente attraverso il logos, come fosse solo un linguaggio. Invece il triangolo perfetto è costituito dall’ethos, nel senso proprio di principio (le ragioni cioè per le quali questo artista dice quello che mi sta dicendo attraverso la sua arte), dal logos (come lo sta dicendo, grammatica e sintassi) e dal pathos (dalla sua capacità di farmi provare emotivamente quello che lui prova nel momento in cui lo prova). Senza anche solo uno di questi criteri non abbiamo un’arte totalizzante ma solo un terzo o due terzi di contenuto artistico.
3. Nel rock le formazioni sono più o meno stabili mentre il jazz ha come propria regola lo scambio ed il frequente mutare di compagni di viaggio. Le dinamiche interpersonali fuori dal palco, l’amicizia, la sintonia fra persone certo influenzano anche la musica che si produce insieme, in un modo che noi ascoltatori possiamo forse solo intuire. Per chi è al di qua del palco che importanza ha la conoscenza e la sintonia fra le persone/musicisti?
Istintivamente mi vien da dire tanta, perchè io amo i sodalizi in musica, ma poi ragionandoci su direi che non esiste una regola: dipende dalle ambizioni, dai contenuti più o meno profondi, anche dall’estetica.
La musica è espressione della vita, e come nell’amore,
talvolta si possono ottenere magie sublimi persino senza una reale profonda conoscenza. Per suonare insieme bisogna innanzitutto amare la musica, e non sé stessi, quindi essere svegli, essere realmente disponibili ad accogliere l’altro, a comprendere l’altro, stare nel presente e sfruttare le proprie abilità e conoscenze al servizio dell’entità musicale, rinunciando ogni secondo ad “essere bravi”. Dopodichè certamente l’estetica musicale è certamente motivo di sintonia, di complicità; avere simili obiettivi estetici favorisce la potenza espressiva, perchè ogni performer si sente attivamente coeso in una ideale combustione/osmosi tra ambizioni personali e ambizioni di gruppo: talvolta si ha la sensazione che siano persino universali, e allora qui il discorso cambia. Come nello sport, o nelle orchestre sinfoniche e nei gruppi rock a cui accennavi, stare bene insieme e avere obiettivi comuni aiuta certo a raggiungere qualcosa che supera la magia, l’incanto del presente. Si tratta di determinare sodalizi che
hanno potenzialità superiori in maniera direttamente proporzionale al numero di elementi che lo compone. Ma è difficile e rarissimo, perchè non solo significa trovare partner empatici e con uguali filosofie ed estetiche, ma significa anche, dato che tutti individualmente siamo in movimento e continua metamorfosi, cambiare insieme negli anni e con gli stessi tempi! Quasi un miracolo ma, intendiamoci: idealmente sono un fautore dei sodalizi in musica!
4. Il tuo percorso ha attraversato diverse fasi per giungere oggi ad una forma espressiva che privilegia il pianoforte solo in una dimensione molto intima che pare avere trovato una “casa” ideale nell’etichetta ECM. E’un punto di arrivo di una lunga parabola o la consideri una fra tante diverse fasi? E quali aspetti sono alla base di questo rapporto con la casa discografica di Manfred Eicher?
La considero soprattutto un enorme privilegio ed una grande responsabilità.
Privilegio perchè la filosofia e l’estetica di Eicher incarna compiutamente quello che da sempre penso della musica, e cioè che non esistono razze e religioni ma solo musica bella o musica brutta, o meglio, bellezza, mediocrità e spazzatura: ECM è l’unico catalogo che veicola musica antica e contemporanea, classica e barocca, folk e tradizionale, mainstream jazz e free jazz, nuove musiche e elettronica, concentrandosi unicamente al proprio ideale di bellezza, dando voce a tutte le regioni del pianeta, con le loro specifiche, differenti caratteristiche identitarie. Responsabilità perchè far parte di un catalogo che annovera la maggior parte dei tuoi punti di riferimento di quanto eri bambino, poi ragazzo adolescente, quindi giovane e ambizioso concertista, innesca in te un senso di partecipazione alla storia delle nuove musiche, significa non solo immergere un piede per godere -da fruitore/ascoltatore- dell’acqua di quel fiume, ma sapere e sentire di essere quell’acqua, percepirsi di fatto parte integrata di quel flusso, contribuire alla sua temperatura, alla forza e alla direzione delle sue correnti. Come ho già ricordato, i miei primi dischi di jazz (o di qualcosa che dal jazz è in qualche misura era influenzato) sono stati due dischi prodotti da Eicher che mi hanno letteralmente cambiato come individuo, modificando nella sostanza il mio sistema percettivo e la mia relazione, già potentemente intima, con la musica.
Dunque si comprende bene cosa possa significare per me collaborare da quasi quindici anni con quella piattaforma per me “iniziatica”: è un vero sogno, e ad oggi il mio contributo è giunto a sette album, di cui tre doppi.
La base del rapporto con Manfred è proprio questo, il destino. Un destino che nasce nel momento in cui il lavoro fatto da un uomo che abita in una regione del mondo diversa dalla mia cambia la vita di un bambino con dei talenti musicali. Quando la forza che innesca un rapporto nel mondo dell’arte proviene da questioni così profonde, la fiducia diviene semplice inerzia naturale di una sostanza ancor più potente e propulsiva fatta di riconoscenza, complicità, empatia, adesione e condivisione.
5. Scrittura ed improvvisazione sono due elementi ricorrenti nella tua musica: c’è sempre un rapporto consequenziale o talvolta ravvisi uno scontro, una dinamica opposta fra il rigore della pagina scritta e la possibilità di esprimere liberamente l’emozione di un momento?
E’ una bellissima domanda a cui già altre volte sono stato “costretto”.
Si potrebbe scrivere un bel saggio di tremila pagine, perchè riguarda tutta l’esperienza della musica, che è l’esperienza più misteriosa e miracolosa che un’individuo possa vivere su questo pianeta.
Questa esperienza totalizzante ogni giorno è uguale, eppure completamente diversa. E’ un miracolo simile ad altri miracoli, ma rispetto ad altri il suo mistero rimane inalterato ed affascinante, come l’amore, o la morte. La luce e l’acqua ad esempio sono due “miracoli”, ma nei secoli li abbiamo studiati e compresi. Li possiamo spiegare, ne conosciamo ogni segreto. La musica, che da secoli viene scritta, studiata, insegnata, studiata, eseguita e giudicata da eserciti di studiosi, rimane ancora oggi un mistero semplicemente perchè è legata all’espressione del sé umano.
E ogni essere umano è uguale all’altro, ma anche completamente diverso. Non solo ma, anche individualmente, nel corso degli anni cambia , potenzialmente ogni giorno, si modifica a secondo delle esperienze, della civiltà culturale, del contesto sociale.
Proprio il mistero è l’aspetto della musica che più mi magnetizza. Se “capisco” tutto mi annoio.
Per questo negli anni sempre di più mi sono definito in un ambito performativo, legato all’improvvisazione spontanea, tabula rasa. Voglio stare in quel mistero.
Ho mantenuto viva la prassi compositiva perchè è uno strumento privilegiato di dialogo, scambio e condivisione con la comunità musicale; infine un preziosissimo strumento di memoria, ogni artista ed ogni artigiano sono chiamati a lasciare una traccia di sé. Una sedia, un’architettura, una ricetta. E’ una memoria della sua creatività, delle sue visioni, delle sue fatiche e competenze. La composizione è come un quadro, una poesia, un libro. E’ un segno.
Ma nei contenuti, se la domanda specifica era questa, per me non c’è differenza tra composizione e improvvisazione. E’ comunque sempre un’oggetto musicale, vorrei tanto che le mie improvvisazioni suonassero come composizioni, con le stesse qualità formali, e che le mie composizioni suonassero come delle improvvisazioni, con quella forza viva della verità e del suo presente, mantenendo l’urgenza espressiva del qui ed ora.
6 .Il tuo recente cd Pelagos fa riferimento in varie declinazioni al tema della migrazione e del mare, e contiene pagine di forte intensità che trasmettono all’ascoltatore l’emozione di chi vive o è testimone di momenti drammatici. Quale era il tuo intento nel momento in cui hai pensato a tradurre in musica questi temi?
Ci sono dei giorni in cui, leggendo le notizie, chi ha una coscienza, o almeno un’etica, non può provare imbarazzo, disagio, talvolta orrore e disgusto. La gente che solca il Mare Nostrum naviga verso una speranza che spesso finisce per trasformarsi in un sepolcro. E poi c’è la Siria. E poi la Somalia. E poi la Palestina. E poi, e poi, e poi…
Non riesco più a vedermi vivere la mia vita di privilegio come fossi in una bolla, separato e senza un ruolo reale nella società reale, completamente avulso dal mondo reale. Reale: senti quante volte questa parola risuona? C’è un momento in cui la nostra comunità, se non palesa segnali individuali continui, rischia di definirsi definitivamente come una comunità di allegri intrattenitori (dunque evidentemente tristi) dediti per lo più alla rappresentazione, con i loro piccoli/grandi problemi di precariato, di visibilità, di sopravvivenza di mestiere, comunque sempre completamente auto referenziale, con i suoi omaggi a Mozart e a Zappa, a Hendrix e alla canzone napoletana, a Modugno e a Bill Evans. Non può essere tutto qui.
Avevo appena registrato il live dedicato alla musica di Alec Wilder e leggo che quasi 400 persone erano morte al largo di Lampedusa. Mi sono visto in quegli anni, chiuso nel mio studio a lavorare sulle musiche di un compositore americano semi-sconosciuto ai più mentre queste persone facevano carte false per salire su barche fatiscenti unicamente per fuggire e trovare una speranza di vita. Io ho quattro figli e mi sono confrontato con quel medico siriano che ha perso tutti e due i suoi figli su quel barcone. Ho provato un fastidio insopportabile, quasi vergogna. Ho sentito che il privilegio della musica poteva portarmi ad una vita un poco irreale, sotto certi aspetti non particolarmente utile. Ho pensato che fosse importante che l’arte in genere dicesse qualcosa nell’unico modo possibile, attraverso la sostanza sottile che è in grado di veicolare, dunque per me attraverso la musica e il pianoforte. Non posso fare politica, ma essere etico sì. E posso anche essere vivo, e sveglio. E dire ad altri esseri umani che io “mi accorgo” di quanto succede, che io ci sono, e sono vicino ai loro cuori, ai loro spiriti. Non è uno schieramento ideologico, non è polemica sull’incapacità della politica di gestire la realtà contingente. E’ il mio legame ai valori dell’umanesimo, compassione (con- passione!), empatia, dolore condiviso, pura umanità.
Questo era l’ethos. Il “mare aperto” di Pelagos per me è l’ideale dialogo in musica tra la civiltà occidentale mittleuropea, i linguaggi che fanno parte della mia vita e tradizione di pianista/musicista europeo, e le civiltà extraeuropee, in particolare quelle dell’area mediterranea, che mi regala la possibilità di confrontarmi con l’arcipelago di culture musicali che più mi hanno influenzato.
Per evidenziare ancor meglio il dialogo ho usato due pianoforti simultaneamente: uno normalmente “ben temperato” e l’altro completamente preparato e fuori dal temperamento, come fosse restituito alla sua genetica di strumento a percussione. Vi sono composizioni ed improvvisazioni extra-occidentali, quasi primitivi e composizioni ed improvvisazioni con lo strumento “classico”. Poi ci sono anche dei brani “osmotici”, nei quali il dialogo è una concreta sovrapposizione dei due strumenti, essendo stati posizionati a specchio, con un seggiolino unico al centro.
7. Che musica ascolti con preferenza?
Musica tradizionale, soprattutto. Da circa ventanni specialmente quelle di derivazione ottomana, arabo andalusa e medio-orientale.
C’è tutto quello che cerco: mistero, culto del suono, melodia, canto e danza. E poi torno continuamente sui compositori che amo di più, sia del 500 che del ‘900. Tanto 700, Bach, Haendel, Scarlatti, Couperin. Con l’età cresce il mio amore per Schubert e l’ultimo Beethoven. Poi, da sempre, Brahms e i russi: Prokoviev
8. Oggi si parla molto di una generale crescita della preparazione tecnica dei musicisti, con gli italiani sempre più apprezzati, ma qualcuno lamenta una carenza di feeling, una difficoltà a sapere esprimere emozioni attraverso il proprio strumento. Che ne pensi?
Argomento assai serio, direi quasi una tragedia, artisticamente parlando. Confermo quanto detto in precedenza: l’Accademia il più delle volte tratta la musica come un linguaggio. Probabilmente anche un pappagallo, chiuso in una stanza per dieci anni a studiare una lingua, imparerebbero a parlare con la giusta grammatica e la giusta sintassi. Molti interpreti classici infatti, ahimè, suonano la musica correttamente: le note sono quelle giuste, i ritmi sono quelli ben suggeriti dalla scrittura del compositore, così come segni di punteggiatura, abbellimento, coloritura, dinamica, espressione, ecc. Eppure spesso non è sufficiente comunque, nonostante le partiture contengano una quantità assai importante di informazioni, spesso sublimi: sono la perfetta sintesi dell’espressione umana, del pensiero, del sentimento e della sapienza dell’individuo che le ha composte, magari duecento anni prima.
Ma la musica ha bisogno di un -perchè lo fai?-, di ethos, appunto, e quindi di un -come lo fai?- che è fatto , sì, per metà di linguaggio (con le grammatiche e la sintassi del linguaggio che l’individuo sceglie come proprio veicolo espressivo), ma per l’altra parte è costituito da pathos. E il pathos è fatto per lo più di natura, di talenti, di cose che -si ha da dire-, di dolori, di vissuti, di esperienze, di memorie.
Sentiamo spesso cantanti che “imitano” Janis Joplin, o Billie Holiday, o Amy Winehouse come fossero delle “custodie vuote”: come se il tormento individuale, i travagli ed i dolori del sé non fossero il motivo stesso della forza espressiva, oppure come se questi elementi fossero trasferibili attraverso la semplice replica di uno stile.
Quanti tenoristi coltraniani senza la vita spirituale di Coltrane? Quanti altisti parkeriani senza la reale disperazione interiore di Bird? Quanti musicisti pseudo-free anemici senza la feroce volontà di autodeterminazione del popolo afroamericano? Queste cose non si possono trasferire in Accademia, non si possono studiare. Il pathos, l’intensità, la verità o ci sono o non ci sono. E quando non ci sono alla musica manca un terzo importantissimo del ruolo che dovrebbe avere sul pianeta: quello di collegare gli animi attraverso un’emozione che da individuale diviene empaticamente collettiva sino ad assurgere ad una condizione universale.
9. Il jazz molto più di altri linguaggi sembra essere al centro di una trasformazione che spesso passa attraverso la fusione con altre culture musicali, ad esempio il soul, l’hip hop l’elettronica, la world music. C’è però anche una forte e radicata ala che resiste a queste contaminazioni. Come vedi il jazz del futuro?
Mi interessa il futuro della musica, e molto. Quello del jazz meno, semplicemente perchè considero il jazz, o meglio i cosiddetti jazzisti, parte della comunità musicale, e dunque amando la musica so di amare per riflesso anche quelle zone del jazz che sono ancora una fiamma viva e vibrante. Mi interessano “le nuove musiche” se espressione di verità individuali e comunitarie, e sono certo che molti improvvisatori di emanazione jazzistica costituiranno corpo e sangue di questa possibile espansione. Oramai la frase -il jazz del futuro- è una contraddizione in termini già da una cinquantina di anni a cui non voglio partecipare, semplicemente perchè non mi interessa immaginare nodi per i quali non esiste soluzione, è un circolo vizioso: jazz è una parola, la musica jazz invece esiste indubbiamente sia come linguaggio-idioma con la sua grammatica e la sua sintassi precisa e poi anche come filosofia di pensiero legato alla prassi dell’improvvisazione, al momento presente, non a caso nutrendosi di libera, spontanea creatività. Come si fa a suonare collegati al momento presente un linguaggio affermatosi come tale, definitivamente, alla fine della seconda guerra in un luogo tanto “particolare” -e mi fermo qui- come gli Stati Uniti? Da un lato questo idioma è in sé la sovrapposizione di diverse culture, dunque una musica meticcia e paradigmaticamente americana, con le sue contraddizioni e la sua propulsiva forza espansiva e conquistatrice lungo tutto il pianeta, con i pro e i contro. Dall’altro non dimentichiamo che è anche -soprattutto per una parte della comunità- il manifesto di un popolo, il popolo afroamericano, che lentamente si è affermato nel tessuto della società, passando da una posizione di schiavitù ad una di inserimento/assorbimento.
Questo travaglio, piuttosto lungo e doloroso (iniziato nel ’46 e terminato -se è terminato- probabilmente con la elezione a presidente di Barack Obama) ha avuto come forma espressiva metalinguistica , manifesto e colonna sonora il jazz, senza dubbio. Ma non scordiamo le diatribe sul jazz nero versus jazz bianco, le accuse di ziotomismo a Armstrong e Ellington, Coltrane che -non suonava più jazz- quando registrava Ascension o Miles che -non era più Miles- quando incominciò a filtrare il suono angelico della sua tromba negli amplificatori distorti. Insomma c’è sempre stata una resistenza un poco reazionaria ad accettare che il jazz, se ridotto ad un linguaggio puramente idiomatico, finirebbe per divenire la -”musica classica afroamericana” con il rischio di smarrire completamente il suo seme generatore che è l’improvvisazione ed il legame con la contemporaneità. In effetti ora il jazz lo studiano in costose università i nipoti di coloro i quali si sono inventati quella lingua. La suonano ovviamente sempre “meglio”, ossia con più controllo tecnico, ma senza ethos, senza un vero motivo. O meglio: senza un motivo così forte come era quello dei loro nonni. E dunque, dal punto di vista del legame con “l’adesso” e la contemporaneità, lo suonano assai peggio. Lo fanno come molti europei ahimè suonano Haydn o Schubert. Bene ma senza la verità del presente. Senza urgenza espressiva. Il grande privilegio delle tradizioni jazzistiche sta proprio nell’epoca nella quale si sono sviluppate, quella del disco, e dunque nella potenziale sottrazione alla rappresentazione, alla sterile replica, in quanto musica
che non ha bisogno di interpreti. Abbiamo tutto registrato! Se è vero che purtroppo non possiamo godere di un’improvvisazione all’organo di Haendel, o al violino di Paganini, o al piano di Chopin, al contrario fortunatamente possiamo per sempre fruire di Ellington che dirige dal piano la sua orchestra; possiamo addirittura vederli in video, che diventa un’esperienza quasi esoterica, ai confini con la seduta spiritica. I giovani del ghetto non amano più davvero il jazz, hanno scelto da trentanni l’hip hop come loro linguaggio di autoaffermazione. Io nei suoi eroi del neoclassicismo non rilevo alcun senso, ma è un’opinione personale che si porta via il vento, perchè di fatto si continua a considerare certe musiche come mero linguaggio. E l’errore è tragico. Io non ho interesse ha pensare nemmeno al classicismo di Mozart e Beethoven come linguaggio, perchè a me della musica interessa il mistero, la fiamma viva: figuriamoci dunque se mi si parla del jazz come linguaggio. Non partecipo: in quel senso, come mero linguaggio il jazz è morto con la contaminazione degli anni sessanta e ora l’argomento sembra davvero fuori tempo massimo. L’idioma non è più riconducibile ad una parola unica: poteva negli anni sessanta Armstrong fare una jam session con Rashied Alì? Potenzialmente sì, fisicamente parlando. E Oscar Peterson accompagnare Ornette Coleman? Errol Garner con Pat Metheny? Ella Fitzgerald cantare nella Liberation Music Orchestra? Non sono forse tutti jazzisti, e anche di prima grandezza, che hanno vissuto lo stesso tempo, sebbene appartenendo a generazioni diverse? E’ come quando si cerca di mettere Scarlatti e Ravel nello stesso contenitore cosiddetto “classico”, o Elvis Presley e Tom Yorke in quello “rock”. Tutto sembra svilirsi, eccessivamente semplificato ad un “genere”, che comprende “stili” diversi.
Insomma Dante è Dante, perchè Ellington deve essere un jazzista? Picasso è considerato forse “un cubista” (non nel senso del ballerino da discoteca, ma di esponente del cubismo…)? No, in ogni caso!
Se volessi sintetizzare direi che qualsiasi musica muore quando le dai un nome. La uccidi lì, sul posto: il jazz muore solo se e quando lo nomini facendoci finire dentro universi poetici di una complessità ed una diversità che meriterebbero attenzione specifica e particolare. Andrebbe probabilmente abbandonata questa parola, o ricordata con tenerezza come si fa con quelle belle auto d’epoca fuori produzione. Magari un raduno ogni tanto, quello sì, perchè l’uomo ha un rapporto sentimentale col Tempo e si è inventato la nostalgia: giusto che la persegua, di tanto in tanto, ma senza confonderla con altro.
10. Qualche accenno a progetti futuri?
Certamente proseguirà la ricerca e l’attività (sia concertistica che discografica) in solo e con il Trio.
Certamente aumenterò collaborazioni con lo strumento voce, mi sono deciso a combinare il mio amore per la poesia con l’attività musicale. Ho in cantiere Anima Mundi, che dovrebbe essere una sorta di manifesto teso ad annullare la divisione in generi, e gli idiomi nella musica sembrano apparentemente marcare queste differenze di genere. In realtà Canto è esistenza poetava Rainer Maria Rilke, e da sempre e per sempre esiste quel luogo dove sotto il velo dei linguaggi le musiche del mondo, manifestazione dello spirito individuale -e per estensione ideale manifestazione di uno spirito collettivo-, sono in realtà tutte unite a formare una sola grande Musica paradigma di una sola grande Anima, a cantare lo stesso grande Canto. Un’anima cosciente che non è un semplice aggregato di elementi composti e ri-composti, riproducibili tecnicamente. Come la vita la musica del
mondo è una continua e incessante creazione che nasce da un principio assolutamente semplice, non rieseguibile deliberatamente, né componibile a partire da nient’altro. Animata da una forza interiore compatta e unitaria, da un’ attività unificatrice che colma differenze di genetica e di cultura nelle quali si polarizza, articolandosi secondo una visione armonica e organica dell’universo. Il genere andrebbe dunque superato, nel mondo come nella musica: è come l’ego che separa le anime individuali, e come l’ego è in realtà illusorio, perché al fondo esse sono una realtà sola; di qui la raccomandazione di esercitare la compassione, tramite cui è possibile riconoscere se stessi negli altri, nell’estasi del ricongiungimento. Per questo abbiamo scelto specialmente le musiche dei paesi in grave difficoltà, dove abita il dolore individuale e collettivo, con l’illusione che l’Anima Mundi possa curarsi attraverso un’ideale rigenerante auto-guarigione innalzando uniti i suoi canti come fosse un’unica vibrante preghiera, un unico canto vitale.
L’Anima Mundi descrive efficacemente un concetto secondo cui ogni realtà viva, anche apparentemente inanimata, contiene una presenza spirituale, collegata all’anima del tutto. Anima intesa semplicemente come nucleo vitale, in un senso universale: seme.
Il mondo della canzone, nell’ultimo secolo un poco instupidito dagli affari, evita ahimè sodalizi con la comunità poetica, per ragioni che non comprendo sino in fondo, e allora mi sono deciso a mettere in musica tanta più poesia possibile, sia contemporanea che di tradizione, sia italiana che in dialetto (il friulano di Pasolini…) che in altre lingue (farò Four Quartets di T.S. Eliot con Theo Bleckmann e Michele Rabbia)
11. Jazz e vino è il binomio al centro di questo libro, vorrei chiederti:
− Ti piace il vino e che preferenze avete in questo settore (tipi di vino es: Pinot, ecc.) ?
Confesso, non senza un velo di imbarazzo, di essere completamente astemio dalla nascita.
− Che analogie e rapporti individui fra i due universi?
Pur non essendo -per ovvi motivi- parte della comunità dei cultori, posso facilmente dire che il vino, come l’olio, mi evoca immediatamente il sangue della terra, una sorta di resina preziosa, di sacro nettare, manifestazione divina. E la musica, come tutte le forme d’arte, in quanto espressione del sé più profondo della natura umana, è certamente la zona divina dell’uomo. E tra l’altro la parola -divino- in sé si presta naturalmente a immediate -facili- assonanze ed analogie…